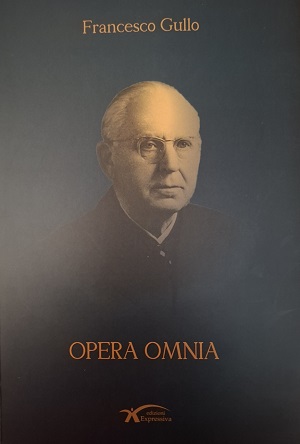L’anima pascoliana di don Francesco Gullo
di
Mario Gaudio
Parlare oggi di poesia è impresa quanto mai impopolare, dal momento che chi frequenta gli ambienti della letteratura in generale e quelli della critica in particolare è consapevole del processo di inflazione che grava sull’arte poetica e che, a conti fatti, può essere attribuito essenzialmente a due fattori: da un lato la riduzione dello spazio vitale riservato alla poesia, considerata dai più rifugio per temperamenti bizzarri o innocuo passatempo per oziosi benestanti, dall’altro la proliferazione incontrollata di poeti ‒ o presunti tali ‒ che si fregiano di contestabilissimi allori semplicemente dopo aver impresso su carta frasette motivazionali spacciate impunemente per poesia con la complicità di fameliche case editrici, di giurie divenute distributrici seriali di targhe e contentini e di narcotizzati addetti ai lavori che han smarrito, più o meno colpevolmente, il senso e il valore della critica militante.
Tale premessa, benché polemica e magari di poco interesse per chi si limita alla semplice fruizione dei testi, è necessaria per addentrarci con consapevolezza nel mondo poetico di don Francesco Gullo (1886-1983), intellettuale che, per quanto lontano dai circuiti culturali di rilievo del suo tempo, è riuscito a tramandarci un lodevole ritratto del vivere e del sentire di una comunità meridionale afflitta da problemi atavici, ma tenacemente legata alla gioia delle piccole cose e alla speranza della fede.
Don Gullo condensa la sua produzione poetica in quattro volumi intitolati rispettivamente Sotto il mio cielo (1955), Tra case e campi (1958), Come foglie d’autunno (1968) e Sunt lacrimae rerum (1974). Essi vengono dati alle stampe nell’arco di circa un ventennio, intervallati da lunghi periodi di silenzio durante i quali l’autore costruisce per gradi il suo edificio poetico, imprimendo ai diversi scritti una perfetta coerenza stilistica e tematica in grado di renderli manifestazione progressiva di un unico pensiero raffinatosi e impreziositosi grazie allo scorrere degli anni.
I versi di Gullo si configurano, sin dalle prime battute, come marcatamente pascoliani, se non nella forma ‒ dacché carenti dal punto di vista metrico ‒ sicuramente nella sostanza, con una larga coincidenza di argomenti e sensibilità che ci consentono di annoverare il nostro autore tra i seguaci del poeta romagnolo.
Il richiamo costante al tema del nido distrutto e alla nostalgia dell’antico tepore familiare esercita su Gullo quel medesimo fascino ‒ doloroso e salutare al tempo stesso ‒ che, decenni prima, Giovanni Pascoli (1855-1912) aveva saputo trasfigurare, con ben altri esiti, in versi rimasti esemplari in seno alla letteratura nazionale.
La dipartita precoce del padre ‒ altra circostanza marcatamente pascoliana ‒ costituisce per il sacerdote spezzanese motivo di canto poetico e di riflessione su una condizione di dolore esistenziale che diventa ancor più evidente dal contrasto con l’armonioso equilibrio della natura. In presenza del bello egli non desiste dal ricordare a se stesso e al lettore il lavorìo di un tarlo che ostinatamente logora il suo animo. Ne è testimonianza un verso della lirica intitolata Fiori in cui l’autore scrive: «Fiori da per tutto… ai piè della montagna. / Solo il mio cuore ha spine, senza fiori… e nel dolore non si lagna!».[1]
Tale devastante sentimento è ben presto acuito da un altro evento luttuoso: la morte del fratello Salvatore, la cui giovane vita fu travolta dalla furia bellica sul Carso nell’agosto del 1917. Gullo, al termine della Grande Guerra, ebbe modo di visitarne la tomba nei pressi di Gorizia e di racchiudere l’impressione di quell’intimo e commovente avvenimento in un unico, lapidario verso: «Un vasto campo, seminato a morte».[2]
Il ricordo dei familiari scomparsi diviene dunque anello di congiunzione con la poesia pascoliana e genera versi di tempra molto simile in cui si lamenta la solitudine del presente in opposizione ad un passato di relativa serenità. A tal proposito, è opportuno ricordare un distico di Allora, breve componimento delle Myricae (1891) in cui Pascoli rimpiange la condizione dei giorni andati in questi termini: «Allora… in un tempo assai lunge / felice fui molto; non ora».[3] Quasi a far da controcanto, Gullo in Rimpianto si abbandona ad un’affine, amara considerazione: «C’era, nella casa mia, allora, / pur tra privazioni e stenti / una grande pace riposante…».[4]
La lezione pascoliana si esplicita in Gullo anche sul versante del rapporto con la campagna. Essa è il tema dominante delle già citate Myricae in cui il poeta romagnolo contempla con bozzetti suggestivi il mutare delle stagioni, soffermandosi con particolare attenzione sull’autunno, momento intermedio in cui convivono i ricordi dell’estate appena trascorsa e i presagi dell’inverno imminente, immagine ideale della morte. Don Gullo non è da meno ed offre gradevoli quadretti poetici in cui il mondo agreste è colto in tutte le sue sfaccettature: dalle assolate giornate estive alle fredde e nevose serate invernali, passando per l’amabile e attesa primavera e il brumoso e decadente autunno.
In ambo gli autori compare un insistente riferimento alla semina, azione ambigua per eccellenza, poiché è fuor di dubbio che il seminare e il seppellire hanno alla base la comune violazione dei recessi della Madre Terra destinata, in entrambi i casi, a portar frutto, come magistralmente insegna la nota parabola evangelica.
Altrettanto pascoliana è la tendenza a celebrare in poesia un’ampia fauna che, per buona parte, coincide in ambedue gli autori. Ecco pertanto che i versi del Pascoli e quelli di Gullo pullulano di rondini, allodole, civette, galletti, cani, gatti e buoi immortalati nella loro azione di ausilio al lavoro umano o nella funzione di allegro annuncio di una nuova stagione o del trapasso dal giorno alla notte.
Comune ai poeti presi in esame è anche la capacità di vedere e circoscrivere le miserie umane, ma su questo punto le strade si biforcano e le soluzioni proposte risultano essere radicalmente diverse. Dinanzi ai problemi sociali e alle infelicità, Pascoli si rifugia in una sorta di umanitarismo generico che si compone di solidarietà e comprensione reciproca e trova la sua espressione nella lirica I due fanciulli in cui due fratellini rissosi vengono messi a letto dalla madre e, nel buio della notte ‒ simbolo del mistero che ci avvolge ‒, dimenticano ciò che li aveva divisi e si ricongiungono in un abbraccio di vicendevole protezione.[5]
Al contrario del Pascoli, Gullo s’indigna davanti a quell’«esposizione di miseria / senza visitatori, senza sfarzo»[6] di cui parla nella lirica Mattino di marzo e di fronte al tristissimo fenomeno migratorio che denuncia nei toccanti versi di Per me non è primavera: «Per me è primavera piena, / quando i miei paesani / non vanno più a cercar / lavoro e pane, altrove, / ma restan, dove son nati, / a lavorare e a morire».[7] Forte del suo ruolo di sacerdote, si impegna a prestar soccorso sia attraverso il conforto cristiano del Vangelo sia per mezzo di un sostegno materiale che si concretizza con la fondazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Spezzano Albanese (1919). Soltanto così egli riesce ad onorare quelle figure che campeggiano tra i versi di 1° novembre a cui si rivolge con gli accorati accenti di un’invocazione: «Santi e martiri, che passano sotto silenzio, / nelle officine, nelle case, nelle casupole, / nei tuguri, per le strade, sui camion, / nei treni, negli uffici, nelle missioni, / negli ospedali, negli asili di bimbi, / di vecchi e di malati! / Quanti santi, quanti martiri, / senza panegirico, che i panegirici / distaccano l’uomo dall’uomo / e l’uomo da Dio!».[8]
Scorrendo le pagine della sua produzione letteraria, Don Gullo appare in molti casi nelle vesti del cantore delle piccole cose. Gli oggetti della quotidianità ‒ il vecchio mortaio, il consunto setaccio, la zuppiera rotta, la pentola in disuso ‒ diventano spunto poetico e tentativo di esorcizzare la morte e stimolare il ricordo di chi non è più. In La lampada della mamma l’autore ripropone il gesto della defunta genitrice, trasformandolo in rito, allo scopo di far rivivere almeno per un istante colei che era stata protagonista di quell’azione, salvo poi comprendere l’irrimediabilità della situazione: «Ora l’accendo io, a sera, la lampada / ma la lampada, che accendo io, non toglie / l’ombra, che mi lasciò in cor la morte».[9]
Gullo ama la propria terra, nonostante sia perennemente gravida di difficoltà. Ne canta le tradizioni, le origini albanesi, il carattere delle genti e ci fa dono di gustose pagine cariche di informazioni etnografiche sulle consuetudini della civiltà rurale.
La religiosità contadina è semplice, spontanea e si nutre di piccoli gesti che hanno, in fin dei conti, finalità propiziatorie: la paglia del presepe vien posta nel nido della chioccia, le botti sono assicurate alla protezione della Vergine o di un santo tramite l’apposizione di immagini sacre, rami d’ulivo benedetti durante la Domenica delle Palme son piantati presso l’uliveto, il vigneto e il campo di grano per chiedere fecondità, mentre l’impasto per il pane lievita solo tracciandovi un segno di croce. Si tratta di simboli, credenze radicate in tempi che non son più e di cui la poesia di Gullo rappresenta, senza tema di smentita, un importante documento per le generazioni a venire.
Si accennava, all’inizio delle nostre osservazioni, alla svalutazione contemporanea della poesia e all’impellente bisogno di ricorrere a modelli di riferimento. Quelli di don Gullo sono i versi delle realtà minime, delle microstorie che illuminano le vite dei semplici, delle sofferenze quotidiane, delle speranze amate e deluse, del calore e dei colori di un tempo, delle voci e delle memorie dei luoghi. Egli, sebbene non sempre ligio alle forme, fu perfettamente incardinato in una tradizione di illustri predecessori ‒ Pascoli in primis ‒ a cui continuare a guardare con attenzione.
Ciò detto, un auspicabile studio organico sul nostro autore si prospetta come valido contributo alla rinascita di un sano e costruttivo dibattito poetico.
[1] Francesco Gullo, Fiori, in Id., Sotto il mio cielo, Gastaldi, Milano, 1955, p. 55.
[2] Id., Dialogo, in Id., Sotto il mio cielo, cit., p. 35.
[3] Giovanni Pascoli, Allora, in Id., Tutte le poesie, a cura di Arnaldo Colasanti, Newton, Roma, 2002 (2001), pp. 13-14.
[4] Francesco Gullo, Rimpianto, in Id., Sunt lacrimae rerum, Fasano Editore, Cosenza, 1974, p. 43.
[5] Cfr. Giovanni Pascoli, I due fanciulli, in Id., Tutte le poesie, cit., pp.150-151. Detta lirica fa parte dei Primi poemetti, la cui prima edizione risale al 1897, mentre la redazione definitiva è datata 1907.
[6] Francesco Gullo, Mattino di marzo, in Id., Sotto il mio cielo, cit., p. 6.
[7] Id., Per me non è primavera, in Id., Sunt lacrimae rerum, cit., pp. 9-10.
[8] Id., 1° novembre. I santi, in Id., Sunt lacrimae rerum, cit., pp. 52-54.
[9] Id., La lampada della mamma, in Id., Tra case e campi, Editrice Mit, Corigliano Calabro, p. 58.