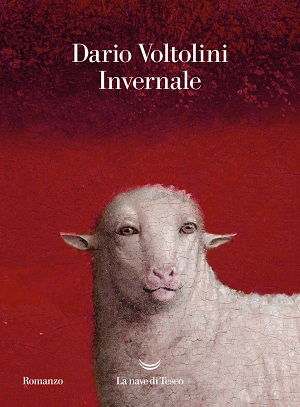“Invernale”: anatomia di un classico moderno
di
Mario Gaudio
Quando Italo Calvino si prodigò nella definizione della nozione di “classico”, ebbe il buon senso di non concludere il concetto, ma di lasciare spiragli aperti sul futuro di una letteratura che, per quanto ormai degradata a mero prodotto commerciale, avrebbe potuto generare qualche testo degno del suddetto appellativo.
Dunque, nella costruzione di una biblioteca ideale, egli consigliò di lasciare «una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte occasionali»[1] e, senza tema di smentita, Invernale di Dario Voltolini trova spazio in questo ricettacolo letterario destinato a durare nel tempo.
Lo scrittore torinese ci regala un romanzo magnetico dal quale il lettore difficilmente riuscirà a staccarsi prima di aver gustato appassionatamente l’ultima pagina.
In esso si consumano le vicende di un uomo e di una famiglia costretti a fare i conti con una realtà terribile e comune: quella della malattia.
Ciononostante, le pagine di Voltolini bandiscono ogni tono querulo e ospitano una narrazione piena di contrasti che si esplicitano tanto sul piano biologico quanto su quello emozionale.
Il personaggio principale, Gino, padre dell’autore, riempie i giorni con il lavoro, trasformando il banco di macelleria di cui è titolare in una sorta di altare sul quale offrire quel sacrificio di tempo, abilità e sudore che si convertirà in sostentamento per sé e per i propri cari.
Le sveglie all’alba, i gesti misurati, le battute di spirito scambiate tra commercianti e il rapporto con i clienti diventano tasselli di un mondo che rassicura e di un equilibrio ingenuamente considerato duraturo, ma dietro cui si cela in agguato l’imprevisto che entra in scena attraverso uno sventurato incidente e una lama che, sebbene destinata a sezionare le carni macellate, penetra in quelle del protagonista.
Il sangue vivo umano si mescola a quello secco della bestia e se da un lato la cruenta ferita lascia sgorgare umori e dolori, dall’altro consente l’ingresso in un corpo sano di nocivi microrganismi che pullulano su muscoli, membrane e viscere di animali non più in vita, ma ‒ condizione paradossale ‒ destinati ad alimentare le vite altrui.
È dunque questo tripudio di carne e materialità che dà l’abbrivio ad una discesa verso i meandri della sofferenza che s’insinua gradualmente tra le membra di Gino, al quale la ferita prontamente ricucita e sanata ‒ al coltellaccio del macellaio si contrappone vittorioso l’asettico bisturi del chirurgo ‒ lascia uno strascico di inspiegabile spossatezza, quasi una sorta di disturbo sulla frequenza, di cui non si riescono a comprendere le cause.
Le avvisaglie della malattia sono blande, addirittura sfuggenti a prime analisi fatte più per scrupolo che per necessità, ma il male principia ad impossessarsi dell’organismo rallentandone impercettibilmente i movimenti e provocando un indefinito languore che stride con la volontà stessa del protagonista ed il suo attaccamento al mestiere.
I giorni scorrono ineluttabili, così come i magici novanta minuti delle partite di calcio che Gino segue con giovanile passione, ma un segno inatteso ‒ imprevedibile al pari di un rigore allo scadere ‒ piomba sull’esistenza sotto forma di minuscola ma palpabile protuberanza sul collo.
L’uomo vigoroso diventa paziente, continua a nutrire lo spirito con la disciplina del lavoro, ma inizia al contempo a percorrere il tortuoso sentiero dell’attesa e dell’incertezza, vere e proprie subdole forme di punizione infernale.
Arriva la diagnosi ‒ o forse il verdetto ‒ e assume le sembianze del cancro, temibilissimo intruso che, si sa, ha «un progetto suicidario, perché quando vince crepa pure lui».
Comincia la battaglia: l’andirivieni di camici e luminari si traduce nel musicale nome di un farmaco, la vincristina, schierata a mo’ di esercito contro battaglioni di cellule ammutinate.
Le forze si riducono, l’animo temprato dalla fatica sugge le ultime linfe dagli affetti e, ad un tratto, la prosa di Voltolini diventa drammatica e speranzosa, sino ad approdare ad un moderno catasterismo ‒ non più mitologico ‒ che tramuta in astro e guida di un personalissimo cielo interiore una figura che fu mentore e modello per brevi ma intensi anni terreni.
Non v’è lieto fine o può darsi di sì ‒ è questione di punti di vista ‒, ma Invernale insegna valori e fortifica il lettore offrendogli l’esperienza del dolore e di una laica redenzione alla quale ognuno può accedere.
È un romanzo breve, probabilmente anche troppo, ma le pagine sono sufficienti ad incorniciare una vita dall’umanità sconvolgente, tanto da divenire paradigmatica. Solo un classico può contenere tale potenza evocativa e il libro in questione ne ha tutte le peculiarità.
[1] Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano, 2012 (1995), p.13.