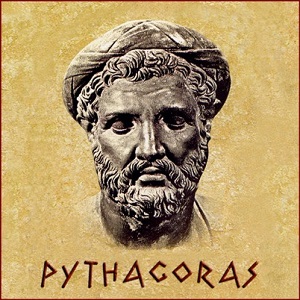Pitagora e le fave: storia di un bizzarro tabù
di
Mario Gaudio
Prendendo liberamente in prestito un felice gioco di parole di Winston Churchill e adattandolo al nostro contesto, possiamo tentare di cristallizzare la figura di Pitagora nell’immagine di «un enigma avvolto in un mistero».
Anche agli occhi dei più attenti studiosi il filosofo di Samo appare sfuggente quanto l’antico dio Proteo e difficilmente inquadrabile in uno stereotipo o, peggio ancora, nei vuoti ed autoreferenziali schematismi della ricerca filosofica. Tutto ciò è dovuto essenzialmente a tre motivi facilmente individuabili: in primis la mancanza di scritti: Pitagora, al pari di Socrate, Confucio e Cristo, ha affidato i suoi insegnamenti all’oralità evitando di imprigionare parole tra gli angusti confini di una pagina; in secundis il carattere esoterico della filosofia pitagorica che, come sappiamo, veniva trasmessa sotto forma di sentenze a comunità ristrette di discepoli vincolati da un rigidissimo voto di segretezza; in terzo luogo la contraddittorietà delle testimonianze dei primi commentatori.
Nonostante questo scenario sfumato e visibilmente indefinibile, Giovanni Sole si è imbarcato nella coraggiosa impresa di raccontare i motivi di un curioso tabù imposto dal filosofo greco ai suoi sodali: l’astensione dalle fave.
Occorre premettere che la vita di un seguace di Pitagora era rigorosamente regolamentata da tutta una serie di prescrizioni ‒ divieto di spezzare il pane o attizzare il fuoco con il metallo, di indossare panni di lana o anelli, di raccogliere ciò che era caduto in terra ‒ ed era scandita dallo studio della matematica e delle scienze naturali. In un quadro del genere, il tabù delle fave appare profondamente fuori luogo o comunque dettato da motivazioni non facilmente desumibili attraverso le categorie di pensiero della moderna società.
Pertanto, per provare a dare una spiegazione, occorre indagare sul ruolo della fava nell’alimentazione e nei culti dell’antichità.
Numerosi scrittori evidenziano la centralità delle fave in alcune importanti festività della Roma pagana: durante i Parilia, il 21 aprile, i pastori erano soliti bruciarle per produrre fumigazioni beneauguranti per la prosperità del bestiame; in occasione delle celebrazioni in onore della dea Flora (Floralia), fave e lupini venivano lanciati contro le donne in quanto simbolo di fertilità; il 1° giugno (calendae fabariae) si onorava Carna, antichissima divinità di origine etrusca, e si preparava la cosiddetta puls fabata, una pietanza di farro e fave che, mangiata insieme al lardo, avrebbe reso immuni dai dolori viscerali; nelle cerimonie dedicate al dio Marte i fedeli si dipingevano il volto con succo di fave che, in questo caso, diventava sostitutivo del sangue.
Tuttavia, il prezioso legume, lungi dall’essere soltanto impiegato in contesti religiosi, era protagonista di alcune raffinate ricette di Apicio ed elemento essenziale della dieta forzatamente povera delle classi popolari.
Appare chiaro dunque che la fava era associata al concetto di fecondità e tale credenza continuò ad essere valida anche in era cristiana: Sole riporta l’usanza, tipicamente palermitana, dei frati di san Francesco di Paola che offrivano alle gestanti alcune manciate di fave nere (“fave palini”) che avrebbero dovuto proteggerle durante la gravidanza; è attestata inoltre la consuetudine contadina di ingrassare i terreni ‒ ed anche gli animali da allevamento ‒ con l’utilizzo del suddetto legume: non è casuale il fatto che, sino a pochi anni addietro, gli agricoltori di alcune regioni italiane si prodigavano a piantare semi di fava ai bordi dei campi per propiziare raccolti abbondanti.
Se l’associazione tra la fava, l’organo riproduttore maschile e la forza generativa appare fin troppo scontata, non può dirsi altrettanto del rapporto col mondo dei defunti e le tradizioni funerarie.
Rievocando nuovamente le festività di Roma arcaica, si incontrano due celebrazioni religiose in cui le fave avevano un ruolo di primo piano: in occasione dell’ultimo giorno dei Parentalia (21 febbraio) ‒ in cui si commemoravano pubblicamente i morti ‒ e durante i Lemuria (9, 11, 13 maggio), circostanza nella quale il pater familias le utilizzava per placare ed esorcizzare gli spiriti dei trapassati che, immancabilmente, tornavano a visitare i luoghi nei quali erano vissuti.
Ad ulteriore conferma del legame con le realtà oltremondane, diversi scavi archeologici hanno rilevato l’abitudine di gettar fave nelle tombe e di consumarle durante i banchetti funebri.
Del resto, la fama sinistra di questo legume è testimoniata da un’ancestrale credenza secondo cui il lungo stelo delle piante serviva da canale di comunicazione per i defunti che, attraverso esso, risalivano dalle profondità della terra alla luce del sole attendendo la reincarnazione proprio nei campi seminati a fave che, tra l’altro, erano gli unici a non essere frequentati dalle api (insetti ritenuti tradizionalmente sacri).
Ancora oggi sussiste un retaggio culinario che rimanda a riti e tempi andati: in qualche regione italiana (Emilia Romagna, Marche, Umbria, Veneto) si è soliti preparare e distribuire, nel giorno della commemorazione dei defunti, dei tipici dolcetti alle mandorle chiamati non a caso «fave dei morti».
Riassumendo: le fave erano associate, sin da tempi remotissimi, all’abbondanza e alla vita ultraterrena, tuttavia esse potevano essere collegate anche ad idee politiche democratiche ‒ dal momento che erano impiegate nel sorteggio dei pubblici amministratori ‒ e ad una malattia tanto insidiosa quanto letale conosciuta come favismo.
Il concetto di impurità ‒ derivante sia dalla reminiscenza del membro virile sia dal contatto col regno dei morti ‒, il monito contro una patologia misteriosa e fatale, una visione aristocratica della società e della vita civile e il fatto che l’astensione fosse un elemento di aggregazione tra gli appartenenti alle comunità filosofiche potrebbero essere alcune delle motivazioni che indussero Pitagora a formulare l’inusuale divieto.
Non esiste una risposta certa in proposito e, del resto, Giovanni Sole, da accorto studioso, mette in guardia il lettore dai pericoli delle soluzioni semplicistiche poiché «[…] Sarebbe ingenuo attribuire un solo significato al tabù, e ancora più ingenuo pensare di trovare la sua origine».
Ciò che resta della avvincente lettura de Il tabù delle fave è condensato in una considerazione preliminare che l’autore stesso ci offre nelle pagine iniziali: «Un tabù è uno dei prodotti culturali più difficili da comprendere. Esso, come il mito, per sua natura è bizzarro e illogico, tende all’occultamento e alla mistificazione del reale, non risponde a delle domande e non dà spiegazioni».
Ben presto, i floridi campi del Mediterraneo furono inondati di bionde spighe, segno di un mutamento tangibile delle abitudini alimentari e della prevalenza della luminosità solare sul violaceo e mortifero colore della fioritura delle fabacee ma, a ben vedere, i miti e i riti della campagna sopravvivono ai secoli e l’apollineo grano continua a crescere accanto alla dionisiaca fava.