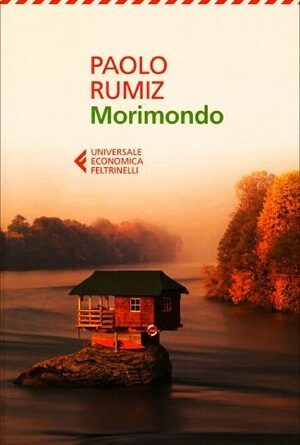“Morimondo”, epopea di acqua e di carta
di
Mario Gaudio
Ci sono viaggi che scuotono le esistenze anestetizzate dall’illusorio scintillio di un capitalismo divenuto sempre più inumano e incapace di contemplare al suo interno spazi riservati alla bellezza e al silenzio.
La tirannia dell’agenda quotidiana, la cancrenosa assuefazione alla superficialità, la malsana abitudine al consumo del non necessario, la diabolica catena della corsa all’iperproduzione ‒ ingannevole miraggio di un altrettanto chimerico benessere ‒ attoscano giorni che inesorabilmente si polverizzano, accorciando vite e riducendo le occasioni per godere di esperienze, persone e luoghi trascurati dalle nostre croniche disattenzioni.
Incapaci di evadere da gabbie senza sbarre impunemente battezzate col nome di “uffici” e stancamente arresi ad interminabili giornate dal sapore di tabacco e caffè, ci arrivano in provvidenziale soccorso alcuni testi in grado di scalfire le artificiose sicurezze, squarciando ingannevoli fondali di scena e aprendo sipari su insospettabili e affascinanti nuove realtà.
Morimondo, partorito dalla prolifica penna di Paolo Rumiz, appartiene a siffatta categoria di libri ed ha la forza ‒ o forse il coraggio ‒ di pronunciare un sacrosanto j’accuse contro l’odierna società acritica e distratta, raccontando di un microcosmo umano carico di valori che vive ‒ o comunque si sforza di farlo con suprema dignità ‒ lungo le rive del Po.
L’autore, giornalista di carriera e instancabile viaggiatore, narra storie, riti e miti dell’italico fiume da un’inedita prospettiva acquatica, compiendo un’avventurosa navigazione da Staffarda ‒ poco sotto le sorgenti del Monviso ‒ sino all’Adriatico, punto di confluenza tra le acque fluviali e marine ed inizio di un nuovo itinerario.
La discesa verso il Delta è affrontata in compagnia di un gruppo di amici entusiasti e diventa occasione di contatto con l’antica cultura rivierasca custodita da gente semplice e tenace, abituata a vivere in simbiosi con il Grande Fiume e ad ascoltarne con sacro riguardo la voce.
Tra le vaporose nebbie mattutine, l’ipnotica danza delle lucciole in mezzo ai canneti e le variopinte livree delle libellule si celano scricchiolanti moli che conducono ad accoglienti osterie immerse in atmosfere dei secoli andati. Attorno ai tavoli siedono uomini e donne del popolo del fiume che, tra un bicchiere di Bonarda e un’anguilla marinata, rievocano gli antichi racconti dei padri impregnati di gratitudine verso il Po, fonte primaria di sostentamento, e di paure ataviche provocate dalle rovinose piene, segno drammatico e tangibile dell’indiscutibile signoria della Natura.
Rumiz raccoglie questi umori, li miscela, li agita, li distilla attraverso gli alambicchi della scrittura, ricavandone una preziosa essenza che profuma di vite logorate dalla fatica, ma ritemprate e rese felici da un corso d’acqua che si trasforma in compagno di viaggio e inesauribile miniera di validi insegnamenti e mai tramontati valori di laboriosità e mutua assistenza.
Il fluire della corrente si trasmuta per Rumiz e compagni in un progressivo processo di liberazione interiore reso possibile dal consolidarsi del contrasto tra la terra ‒ la quale è manifestamente «norma, regola, legge, religione, solco dell’aratro, perimetro del tempio» ‒ e l’acqua che, al contrario, si configura come «spazio sacro ingovernabile, superficie senza recinti né frontiere».
Ne vien fuori un metaforico percorso dalla sorgente alla foce che, a ben pensarci, è, per questi novelli Argonauti e per noi appassionati lettori, una sorta di efficace «riassunto dell’esistenza».
La narrazione di Rumiz ha il potere di coinvolgere tutti i sensi. Priva di infiorettature retoriche, in essa convivono felicemente ‒ brillante amplesso liquido tra inchiostro e acqua di fiume ‒ la facilità dei tratti rettilinei e l’intrico dei passaggi più complessi che conducono a gustose digressioni antropologiche ed ampie parentesi riservate ai succulenti piatti della gastronomia padana, ai sanguigni vini locali e alle espressioni caratteristiche di arcaici dialetti ormai in via di estinzione.
Non mancano incursioni nelle sconfinate regioni del mito che si concretizzano nella riproposizione di vetuste leggende di storioni parlanti, mostruose entità fluviali ‒ tra cui primeggiano il serpentiforme Tarantasio e l’infida Borda, maligna divinità preposta a risucchiare nelle tenebre i malcapitati che sostavano ai limiti dei pozzi ‒ e creature dalle delicate sembianze femminili apparse misteriosamente tra le onde per soccorrere pescatori e battellieri in procinto di annegare.
La sensibilità dell’autore si concentra altresì su pratiche di culto a cui i rivieraschi continuano ad essere particolarmente legati. Tra queste vanno obbligatoriamente menzionate le rogazioni, processioni celebrate per chiedere la salubrità del clima e l’abbondanza e per impetrare protezione divina contro le devastanti piene.
Tuttavia, sotto i campanili che costeggiano gli argini del Grande Fiume non mancano le tracce di antiche forme di devozione popolare nate nella nebulosa epoca in cui residui di paganesimo continuavano a sussistere, nelle aree geografiche più isolate, accanto ad un Cristianesimo non ancora pienamente affermato. Rumiz riporta in proposito due significativi esempi relativi alla notte di san Giovanni: l’accensione di grandi fuochi a Crissolo ‒ allo scopo di allontanare gli spiriti del male ‒ e la consuetudine, diffusa in ampie aree della Padania, di far passare le mucche sulla cenere per stornare dalle stalle e dalla terra gli influssi venefici.
Emerge con chiarezza l’animo del popolo del fiume che ha saputo, nonostante lo scorrere implacabile del tempo, serbare uno stile di vita legato all’eredità culturale degli avi e all’incondizionato rispetto nei confronti del Po. Tutto ciò non può che stupire se si considera che il piccolo mondo celebrato da Rumiz palpita nel bel mezzo dei distretti più produttivi e sviluppati del Paese.
La modernità ‒ o presunta tale ‒ allunga comunque le sue ombre tentacolari su questa battagliera enclave della tradizione rivierasca, manifestandosi attraverso imponenti aborti cementizi che violentano la venerabile sacralità del fiume e ne alterano il corso. Ne è scandaloso modello l’insieme dei resti di una centrale idroelettrica nei pressi di Casalgrasso, opera ingegneristica mai portata a termine, paradigma dello scarso interesse nazionale in materia di tutela delle acque interne.
Se ciò deturpa inequivocabilmente i paesaggi delle terre del Po, non bisogna dimenticare che crimini ancor peggiori continuano ad essere impunemente perpetrati da cavatori abusivi, contrabbandieri, ladri di motori e pescatori di frodo che scorrazzano liberamente a fari spenti nelle fredde notti padane, provocando gravi danni all’economia locale e mutando i delicati equilibri naturali creati dal Grande Fiume nel corso dei secoli.
Al di là di tali incresciose situazioni, il fascinoso viaggio di Rumiz, dopo un indimenticabile incontro con il bardo Francesco Guccini, volge al termine oltrepassando l’agognato Delta e giungendo sull’isola di Sansego, di fronte alle coste istriane.
È da qui che lo scrittore lancia un messaggio di profonda comunione che apparenta fiumi e uomini, epoche ed eventi, concludendo, di fatto, un’epopea di acqua e di carta che val la pena assaporare.